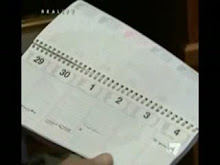giovedì 26 novembre 2009
domenica 22 novembre 2009
Agenda rossa: tutte le verità occultate
La vicenda era iniziata quattro anni prima, il 27 gennaio 2005, quando una fonte riservata aveva segnalato presso lo studio di un fotografo di Palermo l'esistenza di una foto che ritraeva una persona in borghese aggirarsi in via D'Amelio, negli istanti successivi all'esplosione, con una borsa in mano. Una copia della foto viene consegnata agli inquirenti dal fotografo stesso, Paolo Francesco Lannino, il 17 febbraio 2005. La persona ritratta nella foto viene subito individuata nella persona di Giovanni Arcangioli, che viene ascoltato per la prima volta il 5 maggio 2005 dando il via a quattro anni di indagini ed interrogatori, conclusisi nel nulla con il verdetto della Cassazione del febbraio 2009.
E' utile notare come proprio ora, nel momento esatto in cui lo scontro sulla riforma della giustizia è incandescente e le indagini sulle stragi del '92 e sulla presunta trattativa tra stato e mafia stanno entrando nel vivo (portate avanti da ben quattro procure della Repubblica), siano apparse in rete alcune note APCOM che rilanciavano la notizia della decisione della Cassazione, balzata dunque agli onori della cronaca con ben nove mesi di ritardo.
La notizia è di quelle forti: nella borsa del magistrato ucciso, l'agenda rossa non c'era.
Questo è quanto dice la Cassazione, ricalcando le motivazioni presentate dal giudice Scotto per stabilire il proscioglimento di Arcangioli. Motivazioni presentate addirittura il 29 aprile 2008, ovvero un anno e mezzo fa. Oggi, a sorpresa, questa notizia viene riproposta e spacciata come una primizia, come una verità processuale finalmente accertata, che spegnerebbe sul nascere ogni tipo di teoria complottista, tanto cara ai 'professionisti dell'antimafia'. E' forse un modo subdolo per tentare di delegittimare la procura di Caltanissetta, che voleva rinviare a giudizio Arcangioli e che è stata bastonata dalla Cassazione? La stessa procura di Caltanissetta che oggi ha in mano indagini delicatissime sui mandanti occulti? Il sospetto è forte.
E siccome le sentenze della Cassazione non si possono appellare, ma analizzare e criticare ovviamente sì, vogliamo qui mettere in evidenza tutte quelle incongruenze e quelle deduzioni, alcune volte palesemente superficiali, alcune volte (a nostro giudizio) addirittura surreali, che stanno alla base della decisione del giudice Paolo Scotto di Luzio e a cui la VI Sezione Penale della Cassazione, in un paio di paginette, ha dato ragione, senza sollevare alcuna ombra di dubbio.
Ai lettori il giudizio finale sulla ragionevolezza delle nostre osservazioni. In coda al tutto, si potranno trovare i link ai documenti ufficiali.
Cominciamo.
Innanzitutto è necessario sottolineare i casi in cui un gup ha la facoltà di decidere il 'non luogo a procedere'. L'art. 425 del Codice di Procedura Penale al comma 3 stabilisce che uno di questi casi è “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio”. Tradotto: se il pm non ha un briciolo di prova per far condannare l'imputato. La norma serve ovviamente ad evitare che si celebrino processi inutili, destinati a sicura assoluzione, con conseguente sperpero di tempo e denaro. Secondo il giudice Scotto, questo sarebbe stato proprio il caso di un eventuale processo a carico dell'allora capitano del Ros dei Carabinieri Giovanni Arcangioli. Tra le motivazioni di Scotto si legge infatti: “Sussistono nel caso una serie di elementi che si pongono tra loro in contraddizione insuperabile e tale da far ritenere che il vaglio dibattimentale delle medesime fonti di prova, ascoltate ripetutamente in fase di indagine, più di un decennio dopo lo svolgimento dei fatti e destinate ad ulteriore logorio per il tempo trascorso, non consenta di sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio”. Tradotto: le indagini preliminari hanno già detto tutto quello che c'era da dire e un eventuale processo non potrebbe in alcun modo far luce su una vicenda troppo oscura e contraddittoria. Meglio non provarci nemmeno, a far luce. Meglio chiudere tutto in partenza.
Dopo aver presentato tali motivazioni, Scotto passa alla dimostrazione delle stesse.
I FILMATI
Parte dall'analisi di due filmati, quelli che ritraggono per pochi secondi il capitano Arcangioli camminare in via D'Amelio con una borsa di pelle marrone nella mano sinistra, una pettorina azzurra su cui si staglia uno stemma dorato dell'Arma, un marsupio nero attorno alla vita. Sono due frammenti. Il primo inquadra Arcangioli con una borsa in mano, a circa 25 metri dall'esplosione, mentre cammina verso l'uscita di Via D'Amelio. Il secondo lo inquadra a circa 60-70 metri dall'esplosione, sempre con la borsa in mano, in prossimità di via Autonomia Siciliana. L'ipotesi accusatoria è quella che Arcangioli si sia allontanato con la borsa per qualche tempo, si sia appartato per estrarre l'agenda rossa e consegnarla a ignoti o trattenerla per sé, abbia poi riposto la borsa nella macchina del magistrato ucciso, dove sarebbe stata poi raccolta dall'ispettore di polizia Francesco Paolo Maggi.
alt
19 luglio 1992 - Palermo, via D'Amelio: in primo piano
il capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli
Scotto cita una nota della Dia del 7 settembre 2007 dove si dice che “non è neanche possibile stabilire il tempo reale trascorso tra le immagini che inquadrano il capitano Arcangioli con la borsa in mano e quelle che lo ritraggono senza”. Questa osservazione nulla toglie all'ipotesi accusatoria descritta sopra. E' chiaro che non sia facile stabilire esattamente il tempo trascorso tra generiche immagini in cui Arcangioli appare con la borsa in mano e altre immagini in cui Arcangioli ne appare privo. Al massimo è possibile stabilirne una successione cronologica in base ad elementi esterni oggettivi (inclinazione della luce del sole, quantità di fumo presente, ecc.). Ma non è questo il punto e niente ha a che fare con i due filmati in questione. Tanto che Scotto deve prendere atto invece che la nota informativa del 27 novembre 2007 sostiene che i due filmati in esame si possano mettere in successione cronologica. Cioè Arcangioli è partito con la borsa in mano dal luogo dell'esplosione ed è arrivato fino in fondo a via D'Amelio, all'incrocio con via Autonomia Siciliana, sempre tenendo la borsa in mano.
Per il giudice Scotto tutto questo non ha alcuna valenza: “Nulla consente autonomamente di inferire circa la condotta che gli viene ascritta e in particolare di stabilire che la borsa contenesse l'agenda che poi sarebbe stata fatta sparire. (…) Quelle immagini non danno contezza di quanto tempo l'imputato avrebbe trattenuto la borsa, né da sole consentono di sostenere che questi si sia allontanato, non visto, per manipolarne il contenuto. Va inoltre rilevato che nemmeno è possibile sostenere che la borsa contenesse sicuramente l'agenda in questione”. Certo, verrebbe da osservare ironicamente, se ci fosse un filmato in cui si vede Arcangioli che apre la borsa e occulta l'agenda rossa saremmo tutti più felici e non ci sarebbe bisogno nemmeno di discutere se fare un processo o meno. Addirittura, se le telecamere fossero state a raggi X, avremmo potuto vedere direttamente se davvero dentro quella borsa c'era l'agenda rossa o meno. Peccato che, di solito, la colpevolezza di un imputato non sia così facile da dimostrare, anche a fronte di prove schiaccianti. E' chiaro che un dibattimento serve proprio per ottenere informazioni che possano corroborare o smentire quello che appare come una forte prova indiziaria. E cosa c'è di più forte di un filmato che mostra Arcangioli allontanarsi a 70 metri dal luogo dell'esplosione con la borsa in mano?
Scotto non fa un piega: “La direzione percorsa – verso Via Autonomia Siciliana – non è tale da far stabilire che l'imputato abbia sicuramente percorso tutta la Via D'Amelio, al fine precipuo di controllare il contenuto della borsa, non visto, e di celare l'agenda”. Certo, ma il sospetto è forte e oggettivamente fondato. Che senso aveva allontanarsi così tanto dal luogo dell'esplosione con la borsa in mano? Per farle prendere aria? E' un comportamento assolutamente normale o suscita qualche sospetto? O bisogna credere che Arcangioli facesse così con tutti gli oggetti che si trovava sotto mano? Li prendeva e li accatastava in via Autonomia Siciliana? Un copertone fumante qua, un pezzo di carrozzeria accartocciata là, una borsa... Avanti e indietro da Via D'Amelio senza uno scopo preciso? Dove stava portando quella borsa? E a chi? Cose evidentemente non degne di essere approfondite.
MA QUANTE BORSE AVEVA IL GIUDICE?
Il giudice Scotto introduce poi quella che secondo lui sarebbe la testimonianza più attendibile per la ricostruzione dell'accaduto: un verbale dell'ispettore di Polizia Francesco Paolo Maggi risalente al 21 dicembre 1992. Dice Scotto: “Gli unici dati certi circa una borsa appartenuta al magistrato ucciso sono costituiti dal verbale in cui si dà conto che veniva repertata, come priva di ogni rilievo investigativo, alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 5 novembre 1992”. La frase del giudice è a dir poco infelice. Che infatti questi siano “gli unici dati certi” sulla borsa del giudice fa quanto meno sorridere, se si pensa che Scotto sembra ignorare completamente che la borsa non fu in realtà “repertata” il 5 novembre 1992, cioè quattro mesi dopo, ma venne portata in Questura addirittura il giorno successivo, come dimostra la copia della ricevuta. Ma, a parte questo piccolo particolare, c'è un dettaglio da non trascurare nella frase del giudice: il fatto che parli di una borsa e non della borsa del giudice. Cioè, sta introducendo la tesi che poi riprenderà in seguito: la possibile esistenza di più borse tra loro identiche (almeno un paio). Sembra una idea surreale, visto che cozza contro ogni evidenza dei fatti e soprattutto contro le dichiarazioni degli stessi famigliari del giudice ucciso, ma Scotto vedremo che la insinuerà (senza mai sostenerla esplicitamente) con una certa frequenza e insistenza.
Scotto riporta un passo saliente del verbale di Maggi, secondo cui lui stesso “si avvicinava all'auto del magistrato dove un vigile del fuoco stava spegnendo detta auto e lo stesso dal sedile posteriore del mezzo in questione prelevava un borsa in pelle di colore marrone, parzialmente bruciata, il quale dopo avergli gettato dell'acqua per spegnerla, la consegnava al sottoscritto. Immediatamente informava il dr. Fassari della presenza della suddetta borsa, il quale riferiva di trasportarla presso l'ufficio del dirigente di qs. Squadra Mobile”. Scotto cita anche il fatto che, in un verbale successivo del 13 ottobre 2005, Maggi dichiara di essere intervenuto “quasi in contemporanea” ai primi mezzi dei vigili del fuoco (il primo intervento dei vigili del fuoco è delle 17:03). A corroborare la sua ipotesi, Maggi dichiara di aver visto il superstite Antonio Vullo non ancora soccorso, di essersi addentrato nella via D'Amelio, di aver notato la borsa nell'auto, di aver chiesto l'intervento di un vigile del fuoco e di aver prelevato la borsa, che ricorda essere stata “gonfia, quindi piena e pesante”.
Peccato che questa, che dovrebbe essere la prova regina secondo il giudice Scotto, cioè il fatto che Maggi fu il primo in assoluto ad entrare in possesso della borsa del giudice, è una ricostruzione palesemente falsa, che non ha alcun riscontro con tutte le altre dichiarazioni di tutti gli altri testi e soprattutto che stravolge (si spera in modo non voluto) le correzioni successive apportate dallo stesso Maggi. Maggi infatti ha poi precisato di essere sì arrivato in via D'Amelio “quasi in contemporanea con i vigili del fuoco”, ma non di non aver subito esaminato l'auto del giudice. La verità è che Maggi, per sua stessa ammissione, prima di arrivare sul luogo andò a prendere il dr. Fassari a casa sua, poi, una volta in Via D'Amelio, si attivò per soccorrere una bambina e infine fece più volte avanti e indietro in via D'Amelio aspettando che i vigili del fuoco spegnessero gli incendi. Solo allora si avvicinò alla vettura del giudice ed estrasse la borsa. E' chiaro dunque che non è possibile stabilire, come fa il giudice Scotto, che Maggi sia stato il primo a prendere nelle mani la borsa. C'era infatti tutto il tempo, per altri soggetti, di mettere mano alla stessa.
E che sia una tesi che fa a pugni con la realtà è subito dimostrato. Se veramente bisogna credere che Maggi fu il primo a prendere la borsa e ad affidarla a Fassari che la portava immediatamente in questura senza ulteriori passaggi di mano, significa che la borsa che ha in mano Arcangioli, ritratto in foto, è un'altra! Scotto sta dunque veramente asserendo che esisterebbero due distinte borse del giudice Borsellino: una prelevata da Maggi e portata immediatamente in questura, l'altra che, sbucata da non si sa bene dove, compare nelle mani di Arcangioli qualche minuto più tardi. Una tesi quanto mai bizzarra, che è subito demolita da una più realistica ricostruzione dei fatti. Si vedrà infatti che, anche tralasciando tutte le possibili incongruenze delle dichiarazioni dei vari testi, una delle poche cose incontrovertibili della vicenda è che fu Ayala il primo ad intervenire sul luogo dell'attentato e ad occuparsi immediatamente della borsa. Il quadro è confermato dalle dichiarazioni del suo agente di scorta, dal giornalista Felice Cavallaro e persino in qualche modo da Arcangioli stesso. Il giudice Scotto sottolinea il fatto che Maggi dichiarò che la borsa era “piena e pesante”, come a insinuare che dentro ci potesse ancora essere l'agenda rossa e che quindi, nel caso, sicuramente non fu Arcangioli a farla sparire. Peccato che la borsa era pesante, non certo per la presenza dell'agenda, ma perché era impregnata di acqua, gettata da un vigile del fuoco per spegnere un ritorno di fiamma.
Alla luce di questi fatti, è veramente sconcertante leggere che “gli unici dati certi circa una borsa appartenuta al magistrato ucciso sono costituiti dal verbale” di Maggi. Anzi: probabilmente è vero. Il problema è la ricostruzione deformata che Scotto ne fa. Una ricostruzione che oggettivamente non sta insieme e che arriva a sfiorare il ridicolo quando ipotizza implicitamente l'esistenza di due borse identiche. Cosa che, tra l'altro, lungi dallo scagionare Arcangioli, lo metterebbe per assurdo in una posizione ancora più sospetta. Dove avrebbe preso Arcangioli la “seconda borsa” e dove la starebbe portando?
Un ulteriore aspetto che avrebbe dovuto far insospettire Scotto, è il fatto che questa relazione di servizio fu redatta solo sei mesi dopo la strage. Un tempo enorme. Ma Scotto non solo non si insospettisce: utilizza questo particolare come un punto a favore di Arcangioli. Perchè, argomenta Scotto, prendersela tanto con Arcangioli per non aver mai redatto una relazione di servizio, quando anche altri ci hanno messo sei mesi per farne una? Ma che modo di ragionare è? Da quando in qua due mancanze si annullano fra loro? E poi: Scotto è forse l'avvocato di parte di Arcangioli? Non spetta certo al gup stabilire l'innocenza dell'imputato, soprattutto quando questa è reclamata in modo così maldestro, cioè a fronte di possibili analoghi torti altrui.
I TESTIMONI
Il giudice Scotto passa a questo punto ad analizzare le varie testimonianze.
La prima versione di Ayala
L'8 aprile 1998, in tempi dunque non sospetti, cioè sette anni prima del coinvolgimento di Arcangioli, Giuseppe Ayala, che il 19 luglio 1992 era deputato della Repubblica, in un diverso processo, aveva dichiarato: “Tornai indietro verso la blindata della procura anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, se mal non ricordo aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore dove notammo tra questo e il sedile anteriore una borsa di cuoio marrone scuro con tracce di bruciacchiature e tuttavia integra, l'ufficiale tirò fuori la borsa e fece il gesto di consegnarmela. Gli feci presente che non avevo alcuna veste per riceverla e lo invitai pertanto a trattenerla per poi consegnarla ai magistrati della procura di Palermo”.
In questa prima versione è dunque un ufficiale in divisa ad aprire la portiera, ad estrarre la borsa e a fare il gesto di consegnarla ad Ayala, ma lui rifiuta di prenderla in mano.
La prima versione di Ayala, riveduta
Il 2 luglio 1998, sentito al Borsellino Ter, Ayala aveva dichiarato di essere residente all'hotel Marbella, a non più di 200 metri in linea d'aria da Via D'Amelio. Sente il boato nel silenzio della domenica pomeriggio. Si affaccia, ma non vede nulla perché davanti c'era un palazzo. Per curiosità scende giù, si reca in via D'Amelio e vede “una scena da Beirut”. “Saranno passati dieci minuti, un quarto d'ora massimo”. Dice di non sapere che lì ci abitava la madre di Paolo Borsellino. Camminando comincia a vedere pezzi di cadavere. Vede due macchine blindate, una con un'antenna lunga, di quelle che hanno solo le macchine della procura di Palermo. Pensa subito a Paolo Borsellino. “Ho cercato di guardare dentro la macchina, ma c'era molto fumo nero”. Ayala afferma che proprio in quel momento stavano arrivando i pompieri. Osserva il cratere e poi torna indietro. “Sono tornato verso la macchina, era arrivato qualcuno... parlo di forze di polizia. Ora, il mio ricordo è che a un certo punto questa persona, che probabilmente io ricordo in divisa, però non giurerei che fosse un ufficiale dei carabinieri, (...) ciò che è sicuro è che questa persona aprì lo sportello posteriore sinistro della macchina di Paolo. Guardammo dentro e c'era nel sedile posteriore la borsa con le carte di Paolo, bruciacchiata, un po' fumante anche... però si capiva sostanzialmente... lui la prese e me la consegnò. (…) Io dissi: - Guardi, non ho titolo per... La tenga lei. -”
In questa versione leggermente ritoccata, non c'è più la sicurezza di un ufficiale in divisa che apre la portiera, ma permane la certezza che sia stata questa persona ad aprire la portiera e a raccogliere la borsa. Ayala, in ogni caso, nega assolutamente di aver preso in mano e aperto la borsa. “Io poi mi sono girato, sono andato di nuovo verso questo giardinetto, e lì poi ho trovato il cadavere di Paolo. (…) Io ci ho inciampato nel cadavere di Paolo, perché non era un cadavere... era senza braccia e senza gambe”.
Ayala afferma che in quel momento lo raggiunge Felice Cavallaro, che scoppia a piangere e lo abbraccia e gli dice che tutta Palermo lo crede morto: questo perché pochissimi sapevano che lì abitava la madre di Borsellino, mentre tanti sapevano che in quelle zone abitava lui. “Tutta Palermo è piena della voce che ti hanno ammazzato!”
Continua su www.19luglio1992.com
martedì 10 novembre 2009
La soluzione finale
"Sono in discussione in parlamento disegni di legge come quello sulle intercettazioni telefoniche, come quelli che pensano di accorciare ancora i tempi di prescrizione del reato, come quelli che prevedono
Gli unici presidi di controllo rimasti in piedi sono la magistratura e la libera informazione. Su questi snodi, in modo lucido e sistematico, si muovono le iniziative legislative attuali all'orizzonte, quella sulle intercettazioni ad esempio, che costituisce soltanto l'ultimo anello. (…) Ma quel che sta accadendo in Italia, che è accaduto negli ultimi dieci anni (…) e che rende non enfatica, anzi direi quasi un eufemismo, l'espressione che ho usato prima di emergenza democratica, è che noi non ci troviamo tanto o soltanto di fronte a una sistematica demolizione dei pilastri dello stato di diritto. Noi ci troviamo di fronte a una sistematica demolizione dello Stato. Quello che è accaduto negli ultimi anni è una progressiva e radicale rimodulazione del modello istituzionale nel quale la differenza tra quella che in Italia chiamiamo cosiddetta prima e seconda repubblica è che nella prima repubblica vi era una politica che svolgeva un ruolo di mediazione talvolta inquinata da interessi privati e talvolta inquinata anche da interessi criminali, ruolo di mediazione svolto dalla politica che nella seconda repubblica semplicemente non esiste più.
Noi abbiamo detto spesso nel passato che è errata l'immagine “scontro politica-giustizia” anche perché c'era solo una parte che picchiava contro l'altra, e cioè la politica contro la giustizia. Ma io dire un'altra cosa. Noi invece non abbiamo avuto un assedio della politica contro la giustizia. Noi abbiamo semplicemente perso la politica, perché le istituzioni e la politica sono state occupate dagli affari e dagli interessi privati. E quindi è il privato che ha sostituito il pubblico. La differenza quindi tra la prima repubblica e la seconda è che è saltato qualsiasi ruolo di mediazione che la politica svolgeva nella cosiddetta prima repubblica. Questo è quello che mi allarma e mi preoccupa.
Siccome, come ci ricordavano uomini come Falcone e Borsellino, la lotta alla mafia non la puoi fare soltanto dentro i palazzi di giustizia con le indagini e coi processi. Dentro i palazzi di giustizia devi fare appunto le indagini e i processi. Con le prove, se ci sono e se non ci sono le prove non fai né l'uno né l'altro. Ma per affrontare la mafia, che non è soltanto un'organizzazione criminale, ma che è un sistema di potere criminale, la magistratura da sola non può vincere questo scontro. Occorre un movimento ampio, di opinione, della società ed è quello che Paolo Borsellino diceva con una frase, che se noi dicessimo oggi saremmo accusati naturalmente di essere politicamente schierati, che il nodo - diceva Paolo Borsellino – della lotta alla mafia è essenzialmente politico, perché prima di una magistratura antimafia occorre una politica antimafia.
E quindi io da magistrato non voglio un'assenza di politica da invadere con la mia azione giudiziaria. (…) Io voglio una Politica che sia con la P maiuscola e non la p minuscola. Una politica cioè che sia luogo dove vengono perseguiti gli interessi pubblici e non gli interessi privati e che quindi la politica antimafia sia nell'interesse dei cittadini soprattutto e quindi una politica che abbia tra le sue priorità la lotta ai poteri criminali e non ne venga invece invasa, condizionata, subendone le infiltrazioni e che abbia a cuore, perché ne costituisce un presupposto, una magistratura autonoma, indipendente, responsabile (perché la magistratura deve essere naturalmente responsabile e deve rispondere per le sue colpe, ma non per colpe inventate).
Non si tratta di assumersi sulle spalle nessun progetto politico. (…) Dalla magistratura viene una richiesta di politica alla politica (…) e non di fare la guerra alla magistratura.
Di fronte a un quadro nel quale noi abbiamo perso un'opinione pubblica critica perché sull'opinione pubblica vengono rovesciate falsità, luoghi comuni, i fatti non vengono raccontati, ogni fatto viene trasformato in opinione, abbiamo un livello di imbarbarimento del dibattito pubblico, soprattutto il dibattito sulla giustizia, che credo anche questo sia senza precedenti. L'uso della menzogna in politica che è tipico dei regimi si è in modo preoccupante particolarmente accentuato negli ultimi anni soprattutto sui temi cruciali. Raccontare delle letterali “palle” come quelle che sono state dette sul tema delle intercettazioni, sul fatto che tutti gli Italiani siano intercettati, “palle” come quelle che in altre parti del mondo la legislazione sia più garantista che quella in Italia... (…) il problema delle spese non si risolve abolendo le intercettazioni. (…) Se si eliminano le intercettazioni per ridurre le spese, forse chissà che l'obiettivo non è quello di ridurre le spese, ma è di ridurre le intercettazioni e i poteri del pubblico ministero.
C'è un obiettivo di autoconservazione della classe dirigente di cui questa classe politica è espressione, di una classe dirigente che realizza per via legislativa quello che realizzava un tempo altrimenti.
La magistratura di qualche decennio era forte con i deboli e debole con i forti. Poi la magistratura cambiò e venne invasa da un'altra generazione di magistrati che prendono come modelli Falcone e Borsellino e che applicano la legge uguale per tutti.
Ecco che allora è come se si fosse rotto un patto, un patto di non belligeranza, interno alla classe dirigente, nel quale un pezzo di classe dirigente (...) nella sua grande prevalenza ha rotto questo patto di non belligeranza e ha iniziato ad applicare la legge in modo eguale nei confronti di tutti finendo per portare sul banco degli imputati altri appartenenti alla classe dirigente e talvolta anche altri magistrati, altri uomini politici, altri imprenditori. Di qui sono scattati gli anticorpi, di qui si è avviato un progetto lucido, determinato, che viene da lontano e vuole andare lontano, di revisione della legislazione per realizzare il medesimo obiettivo: l'autoconservazione di una classe dirigente che costituisce la vera anomalia del nostro paese.
Si è realizzato in Italia quello che non un magistrato giustizialista, ma un intellettuale pacato e che per altro si occupa spesso di altro, di arte e letteratura, come Pietro Citati, disse tempo fa in un lucidissimo articolo di quel processo di “mafiosizzazione” del paese che si è realizzato negli ultimi anni. Noi, questo processo di “mafiosizzazione” lo vediamo, lo vediamo ogni giorno e quello che più ci preoccupa è quello che ha fatto sì che non solo degli interessi privati hanno invaso le istituzioni spazzando via la politica nel senso più nobile del termine e ha fatto sì che anche interessi squisitamente criminali sono entrati e hanno invaso anche le istituzioni.
Mi sento, come tutti gli Italiani, un po' figlio della trattativa tra stato e mafia perché quel che noi abbiamo intorno probabilmente è anche in qualche modo frutto di quella trattativa. E allora, se così è, noi abbiamo il diritto di sapere chi sono stati i nostri padri, cioè i padri di quella trattativa per potere sapere quale è stato il nostro passato, soltanto così possiamo fare i conti col nostro presente e il nostro futuro.
La nostra àncora di salvezza è la carta Costituzionale. La Carta Costituzionale che credo vada difesa in tutti i modi e ha costituito la bussola della parte migliore del nostro paese. E a questa ci dobbiamo attenere.
Il nostro compito è quello di contagiare l'altra Italia, l'Italia dell'indifferenza, che ha finito per dare ragione con la sua indifferenza e la sua neutralità ai poteri criminali. Io credo che non sia tempo di neutralità. Credo che sia tempo di schierarsi dalla parte della Verità e della Giustizia".
Antonio Ingroia, procuratore aggiunto di Palermo, 7 novembre 2009
lunedì 9 novembre 2009
Una scelta di vita
Massimo è il classico rampollo “casinista, pecora nera della famiglia, inconsistente, senza spina dorsale, viziato, cresciuto nella “bambage”, dedito alla gnocca e a tutti i vizi di questo mondo grazie all’uso ed abuso dei soldi di papà” oppure è un furbetto “che la vicinanza al padre, nel tramonto della propria vita quindi al massimo della saggezza e dell'amore paterno, ha fatto maturare, sbocciare, “allignare” in tutta la sua intelligenza e con la consapevolezza delle proprie origini e storia familiare”?
Una lettera che contiene indubbiamente spunti interessanti di riflessione e che ci restituisce un Massimo Ciancimino “più umano”, con tutti i problemi e le paure di chi, per sua stessa ammissione, si ritrova a destreggiarsi in un gioco più grande di lui. Con tutti i ragionevoli timori e difficoltà di chi, in qualità di figlio, si trova a dover parlare delle colpe del padre e, in qualità di padre, ha la necessità di tutelare l'incolumità della moglie e del figlio, che “a giorni festeggia il suo quinto compleanno” e a cui, non a caso, è stato dato il nome di VitoAndrea, “non aderendo, a differenza dei miei fratelli, - dice Massimo - all’ennesimo invito Paterno a non dare a nessuno dei nostri figli il nome del Nonno Vito”.
E qui trapela l'orgoglio, tutto siciliano, di portare quel cognome così pesante, un cognome che immediatamente rimanda, nell'immaginario collettivo, al “sacco di Palermo”, a collusioni pericolose, a fatti di mafia. Non che Massimo sia uno stinco di santo, né che miri a passare per tale. Anzi. Ha ben presente i propri errori (è stato condannato per riciclaggio del denaro del padre), non ne fa mistero, non ha alcuna vergogna di parlarne, quasi ostentando quella naturalezza con cui ha ammesso di fronte ai giudici di avere sbagliato, e quindi pagato. Anche questo fa parte del personaggio. Narcisista? Può darsi. Sfrontato? Non parrebbe. Quel che è certo, e che ci tiene a sottolineare, è la sua diversità dagli altri quattro fratelli. Fa presente che, sebbene inizialmente fossero tutti e cinque sotto indagine, solo lui poi fu rinviato a giudizio, mentre, per quanto riguarda i fratelli, “stranamente le loro posizioni, su richiesta della procura, vengono archiviate perché niente prova circa la loro conoscenza sulle attività politiche del padre, quindi le origini del denaro”. E' quel termine, “stranamente”, la chiave di volta del pensiero di Massimo. Ritiene, a torto o a ragione, di essere stato preso come capro espiatorio: lui unico confidente del padre, lui unico custode di verità indicibili, lui unico conoscitore e gestore del tesoro di Don Vito.
Non lo dice per discolparsi, ma per dimostrare in modo provocatorio come, se c'è un epiteto che non gli si addice, è proprio quello di “cretino”. Avrebbe potuto un cretino scapestrato, dedito solo ai vizi e alle donne, gestire un patrimonio enorme come quello ereditato dal padre? Ma è lui, Massimo, il primo a sapere che, soprattutto in Sicilia, “è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”. E i pregiudizi su di lui, inutile nascondersi, fioriscono e proliferano. Soprattutto da quando ha iniziato a parlare e a “vuotare il sacco”. Perché ha deciso di parlare solo adesso dopo così tanto tempo? Perché non ha denunciato il padre quando era ancora in vita? Perché non si è offerto volontariamente ai magistrati, ma ha atteso che i magistrati venissero da lui? Forse temeva di perdere i benefici derivanti dal tesoro di Don Vito e ora che tante verità stanno venendo alla luce tenta di salvare il salvabile? Forse sta tentando di accattivarsi i magistrati per avere degli sconti di pena?
Quando Massimo fu chiamato per la prima volta da Ingroia e Di Matteo nel gennaio del 2008, aveva messo in conto tutto questo. Aveva messo in conto che gli sarebbero piovute addosso miriadi di critiche. Aveva messo in conto che le sue rivelazioni avrebbero scatenato polemiche violente. Aveva messo in conto che sarebbe stato sottoposto ad un sistematico tentativo di delegittimazione. E aveva messo in conto, soprattutto, che avrebbe messo a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia. Nella lettera a BlogSicilia, Massimo Ciancimino si lascia andare e racconta di un episodio che fotografa bene, nella sua semplicità e, in un certo senso, normalità, la situazione famigliare che sta vivendo in questo momento: “Proprio ieri, in seguito ad una frase sicuramente detta nell’ingenuità ed innocenza che li contraddistingue, (nello specifico un compagno di classe gli ha detto che il suo Papà dice sempre che prima o poi ammazzeranno il padre di VitoAndrea…) ho cercato di parlare con Lui di cosa sta accadendo nella nostra vita familiare”.
E' chiaro che chi si mette a sparare sulla “memoria ad orologeria” del figlio di Don Vito, contando sul fatto che sui Ciancimino sia possibile dire di tutto per il semplice motivo che portano quel cognome, non comprende, o non vuole comprendere, come dietro ad una decisione tanto travagliata come quella di iniziare una delicatissima collaborazione con la giustizia, che potrebbe riscrivere la storia del nostro paese degli ultimi vent'anni, vi siano sempre degli uomini con le proprie paure, le proprie debolezze e, soprattutto, i propri affetti personali da tutelare in ogni modo.
Anche questo, Massimo l'aveva messo in conto. E per questo non si tira indietro e risponde con pazienza alle critiche, da quelle legittime a quelle più gratuite. Spiega che se ha aspettato fino al 2008 per parlare con i magistrati non è stato per suo vezzo personale, ma semplicemente perché nessun magistrato (anche, aggiungo io, tra coloro che in questi giorni pontificano di “legittime” trattative tra mafia e stato in vista di una cessazione della strategia stragista) fino ad allora si era “ricordato” di chiamarlo, lui che costituiva la memoria storica del defunto padre, per anni cardine fondamentale e imprescindibile di quell'ingranaggio perfettamente oliato che permetteva l'interazione tra le istituzioni da una parte e Cosa Nostra dall'altra. E lui è il primo ad essere rimasto stupito di questa incomprensibile “dimenticanza”.
Ci sono voluti due magistrati come Ingroia e Di Matteo sotto la guida del procuratore capo Messineo per capire che le cose che sicuramente Massimo sapeva potevano dare un impulso decisivo alle indagini. Ci è voluta, ancora prima, una lunga intervista al giornalista di Panorama Gianluigi Nuzzi, che in parte fu lo spunto per un articolo “Vi racconto Mio Padre don Vito Ciancimino” pubblicato dal settimanale nel dicembre del 2007, per accendere i riflettori su di lui e sulle rivelazioni che avrebbe potuto fornire. E per quei magistrati della procura di Palermo, di Caltanissetta e di tutte le altre che da mesi lo stanno ascoltando, Massimo Ciancimino ha parole di profonda stima e riconoscenza: “Posso soltanto dire di aver trovato magistrati come Ingroia, Di Matteo, Lari, Scarpinato ed altri che non hanno mai mancato di giusta attenzione alle mie parole, sempre liberi da qualsiasi forma di pregiudizio rispetto al contenuto delle mie risposte”.
A volte è strana la vita del magistrato antimafia: apprezzato e stimato proprio dai collaboratori di giustizia (che di solito mostrano di avere un gran fiuto nel saper scegliere i magistrati migliori a cui affidare le proprie rivelazioni) e delegittimati da coloro che rappresentano le istituzioni e si autodefiniscono servitori dello stato. E' successo a suo tempo a Giovanni Falcone con Tommaso Buscetta, è successo a Paolo Borsellino con Vincenzo Calacara e Gaspare Mutolo, è successo a Giancarlo Caselli con Balduccio Di Maggio, succede oggi ai magistrati di Palermo e Caltanissetta che vengono accusati dal presidente del consiglio di utilizzare i pentiti per cospirazioni politiche e addirittura da uno dei simboli della caccia ai latitanti, il capitano Sergio De Caprio, il mitico capitano Ultimo, di essere dei “servi di Riina” per aver dato credito alle dichiarazioni di “un servo di Riina come Massimo Ciancimino”.
Ma anche questo, Massimo Ciancimino l'aveva messo in conto: il collaboratore di giustizia è credibile fino a che serve a far catturare altri latitanti, nel momento in cui le sue dichiarazioni possono diventare pericolose per i pesci grossi, viene delegittimato e crocifisso. E' per questo che, quando qualcuno gli chiede di spiegare il suo silenzio durato così tanti anni, Massimo non si scompone più di tanto e dice: “Credo debba girare la domanda ad altri”. Ed è anche per questo che lancia un appello vibrante, non agli uomini dello stato, ma alla “progenie di Riina e Provenzano” perché seguano il suo esempio di “figlio della mafia” e decidano di mettere a disposizione della giustizia tutto il patrimonio di conoscenze che hanno acquisito in qualità di testimoni diretti. “Credo che anche i figli di Riina e Provezano potrebbero fare qualcosa in tal senso, sarebbe un grande passo”.
Non ci tiene a passare per eroe. A chi gli chiede “Ma chi te lo fa fare?” si schermisce e tenta di ridimensionare il suo ruolo. Ripete che non sta facendo nulla di eccezionale, sta semplicemente rispondendo alle domande che i magistrati gli fanno, portando i documenti che i magistrati gli dicono di portare. D'altra parte è assolutamente cosciente del “non semplice ruolo di testimone diretto o indiretto di fatti riguardanti le collusioni politico affaristiche mafiose degli ultimi venti anni, anni - dice - in cui mio Padre sicuramente esercitava una importante figura tra gli attori principali”.
Se è vero, come si dice, che “le colpe dei padri non debbono mai ricadere sui figli”, per Massimo Ciancimino questo detto dovrebbe valere ancora di più. Primo, perché nel momento in cui la magistratura l'ha chiamato in causa, non si è tirato indietro, non si è nascosto dietro i “non so” e i “non ricordo” di cui abbondano le dichiarazioni di illustri ministri ed ex-ministri. Secondo, proprio perché “nessuno gliel'ha fatto fare”. Di vantaggi, è facilmente dimostrabile, ne avrebbe avuti decisamente di più a starsene zitto. Dice di star facendo tutto quello che sta facendo semplicemente perché pensa “di poter essere utile”. E scusate se è poco.
“Non si può sceglier dove nascere ma sicuramente si può sceglier come vivere”, spiega Massimo Ciancimino. Frase che Salvatore Borsellino potrebbe far sua, conoscendone perfettamente il significato e avendola in un certo senso sperimentata sulla propria pelle, quando da giovane si allontanò da Palermo per tentare di sfuggire al “puzzo del compromesso morale” che ammorbava l'isola. Solo per scoprire, molti anni dopo, che quel cancro si era esteso in tutto il paese e si era trasformato in una vera e propria metastasi che veniva a bussargli alla porta, alle porte di Milano. Non a caso, forse, uno dei pochi che ha avuto il coraggio di dimostrare a Massimo Ciancimino vicinanza e riconoscenza per le preziose informazioni che sta fornendo ai magistrati (tra cui brilla la copia del famigerato papello) è stato proprio Salvatore, colui che da anni si batte in prima persona con coraggio veemente perché si arrivi finalmente alla Verità e alla Giustizia sulle stragi del '92.
Lui, sicuramente, ha scelto come vivere.